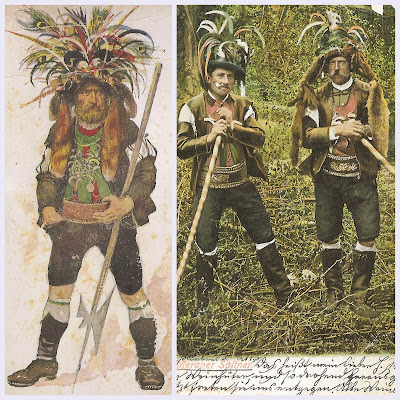Il maso autosufficiente Höfila della Val Pusteria rappresenta bene la condizione del contadino medio.
 |
In Pusteria e in altre valli del Tirolo si dice «casa con focolare» e in Valle Aurina «casa
vera», un genere di costruzione come il maso «Höfila» di Pieterstein nel Comune di
Mühlwald. Fino al 1979 la casetta era abitata e piena di vita. Il trasporto nel museo di
Dietenheim/teodone ebbe luogo nel 1979. |
Il maso «Höfila» viene nominato negli antichi libri fondiari del convento di Sonnenburg.
Il semplice edificio con tetto a due spioventi ed essiccatoio a campana, è posto su uno zoccolo in muratura di 10 metri per 12 e non ha locali interrati.
Un largo corridoio da grondaia a grondaia determina la distribuzione dei locali: a piano terra verso valle stube, cameretta e cucina, a monte dispensa e cantina.
 |
Al piano superiore verso valle ci sono la Stube, la stanza da letto dei padroni, la cu-
cina, la stanza delle ragazze. Verso monte camera dei ragazzi e dei familiari. |
 |
| Vista esterna dal lato a valle. |
A prescindere dalla muraglia verso il monte, tutta la casa è costruita con tronchi di larice. Gli spiragli più grossolani delle pareti erano stati turati con del muschio, cacciato fra i travi al momento della costruzione, e con brandelli di stoffa. Tuttavia quelle camere erano rimaste dei locali freddi e inospitali, dove il vento soffiava e spingeva talvolta la neve sopra i letti.
L'unico locale che si poteva riscaldare senza fumo era la stube, e la relativa stufa veniva accesa e alimentata dal corridoio. Qui si può capire l'importanza della stube, di fronte alla cucina piena di fumo e alle stanze fredde e piene di correnti d'aria.
Due generazioni fa non c'erano né focolari economici né luce elettrica. E soltanto in pochissime case c'era acqua corrente.
Il fumo poteva venire ridotto utilizzando della buona legna secca, ma non eliminato del tutto. Perché qui c'entra un po' anche il tempo, la pressione dell'aria, il vento o il sole che batte sul camino in ogni modo il fumo era spesso causa di male agli occhi e ai bronchi, come testimoniano le molte tavole votive in onore di Santa Ottilia, come ringraziamento per le guarigioni degli occhi, e le molte acque miracolose, di cui una scorreva nel vicino Haselried, dove fino a non molti anni fa, parecchia gente veniva a bagnarsi gli occhi, perché ne aveva estremo bisogno.
Un'altro inconveniente che limitava le possibilità di lavorare e di muoversi era l'oscurità della notte. Minuscole luci per non dire lumicini c'erano soltanto nella cucina e nella stube. E come si doveva essere prudenti con il legno resinoso, con i lanternini e con le fiaccole! Adesso che, premendo un pulsante si può inondare di luce casa e cortile, non è facile neppure capire l'opprimente paura dagli spiriti dei nostri antenati in tutte le sue molteplici espressioni.
 La fontana.
La fontana.
Davanti alla casa, tra la parte abitata e il fabbricato rustico, c'è la fontana, chiamata una volta semplicemente «canale» (trogolo).
Questa forma di fontana con tetto è molto diffusa in Pusteria ed era l'unico posto per attingere acqua in tutto il maso.
Qui si abbeverava il bestiame due volte al giorno Qui la gente veniva a lavarsi, almeno nella stagione più calda. L'imponente trogolo di pietra, ricavato da un unico blocco di granito, proviene dalla zona del Schwarzenbach in Valle Aurina.
Si dice che lo scalpellino abbia ricevuto, per il suo lavoro, il valore corrispondente di tre capre, e ci siano voluti ottanta uomini per trascinare il trogolo nel maso. Era l’anno 1920.
Accanto al trogolo c'è un focolare, chiamato «Seachte», composto semplicemente da una grossa caldaia di rame e da una robusta griglia.

Vi si faceva fuoco quando occorrevano grandi quantità di acqua bollente per lavare (la biancheria veniva fatta bollire nella lisciva di cenere, bruschinata, e, dopo l'aggiunta di turchinetto, risciacquata); per fare il bagno alle pecore in primavera e in autunno prima della tosatura, per scottare e togliere le setole al maiale macellato e per altre eventuali grandi pulizie.
Il forno per il pane.
Del maso fa parte anche un forno per il pane, che nelle zone con costruzioni in legno è, a causa del pericolo di incendio, un po' in disparte, come edificio a sè. Ma nelle zone dove prevalgono le costruzioni in pietra, si possono vedere ancora dei forni sporgenti come Erker dal muro della casa.

Quasi dappertutto il pane lo si cuoceva due o tre volte all'anno in grande quantità. Lo si conservava in stanze ben areate in apposite rastrelliere appese al soffitto per eludere le visite dei topi.
La stalla e il fienile.
Sono situati in un edificio poco distante dall'abitazione. La struttura è in tronchi e porta un tetto piatto di scandole a più strati.
Al piano terra c'è un grande atrio, chiamato più precisamente corte, che va da uno spiovente all'altro. Da qui si arriva alle stalle: quelle grandi per i buoi e i cavalli, quelle piccole per le pecore, le capre cornute, che vengono legate con delle catene, i maiali e il pollame. Anche la tettoia del fieno, con l'enorme mucchio che arrivava fino al tetto, si può raggiungere da qui comodamente.
E lungo le pareti di questa «corte» si ammucchia lo stallatico fresco dell'inverno, per portarlo poi fuori con la buona stagione. Ma non dappertutto si faceva così.

Il piano di sopra è il fienile vero e proprio, il deposito per le riserve di foraggio e per suppellettili ed oggetti di ogni genere. E infine nella parte più alta verso il monte oltre il ponte del fienile, che è accessibile con carro e cavalli, c'è l'aia (
Pirl) cioè il luogo dove ai lati del granaio venivano accatastati i covoni, al coperto, e divisi secondo il tipo di grano.
Per evitare che il tetto potesse crollare sotto il peso di grandi masse di neve, sono stati inseriti sotto la trave di colmo ed appoggiati sui montanti, dei gioghi ricavati da tronchi di alberi cresciuti ricurvi. Il deposito dei foraggi risale al diciassettesimo secolo, ma nel corso degli anni ha subito alcune modifiche. Fino alla primavera del 1984 esso si trovava a Unterpurstoan in Val di Taufers. Accanto al fienile, in un fabbricato aggiunto, c'è l'officina con un banco da falegname per piallare e per bloccare, dove si facevano oggetti di ogni genere e si riparava ciò che si rompeva.
L'ultima foto ritrae una porzione della stalla con le "postazioni" delle singole mucche ed un dispositivo per vagliare il grano: separava i chicchi più grossi da quelli più piccoli, eliminava le impurità ed era azionato a mano.